Corte Costituzionale - Sentenza n. 148 del 25 luglio 2024
Con la sentenza n. 148 del 25 luglio 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 230 bis del codice civile,  nella parte in cui non prevede come familiare anche il “convivente di fatto” e come impresa familiare quella in cui collabora anche il “convivente di fatto” e conseguentemente anche dell’art. 230 ter del codice civile che accorda al convivente di fatto una tutela significativamente più ridotta rispetto a quella garantita dall’art. 230 bis del codice civile per il familiare.
nella parte in cui non prevede come familiare anche il “convivente di fatto” e come impresa familiare quella in cui collabora anche il “convivente di fatto” e conseguentemente anche dell’art. 230 ter del codice civile che accorda al convivente di fatto una tutela significativamente più ridotta rispetto a quella garantita dall’art. 230 bis del codice civile per il familiare.
(di Domenica Cori, Centro studi Aniv)
Con la sentenza n. 148 del 25 luglio 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 230-bis, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella in cui collabora anche il «convivente di fatto». Conseguentemente, ha dichiarato anche l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-ter del codice civile che accorda al convivente di fatto una tutela significativamente più ridotta rispetto a quella garantita dall’art. 230 bis per il familiare.
Il caso che ha portato alla storica pronuncia ha riguardato una convivente che aveva avviato un’attività commerciale e aveva prestato attività lavorativa a favore di un soggetto già coniugato con altra donna, dal 2004 al 2012, anno del decesso di quest’ultimo. La Corte di Cassazione aveva chiesto l’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite che aveva rimesso la questione alla Corte Costituzionale.
Il rimettente aveva infatti sottolineato come l’esclusione del convivente more uxorio dall’impresa familiare di cui all’art. 230 bis del codice civile e la non applicabilità retroattiva dell’art. 230 ter del codice civile si ponesse in contrapposizione all’art. 2 della Costituzione che: “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”, nonché dell’art. 4 della Costituzione il quale “riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro” come strumento non solamente di guadagno, ma anche di affermazione della propria personalità e degli artt. 35 e 36 della Costituzione che, rispettivamente, tutelano il lavoro e riconoscono il diritto ad una “retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro”.
La normativa si porrebbe anche in contrasto con normative comunitarie (art. 9CDFUE) e pattizie (artt. 8 e 12 CEDU), le quali riconoscono e tutelano sia il diritto di sposarsi che quello di formare una famiglia indipendentemente dal matrimonio. La Corte Costituzionale ripercorre nella sentenza n. 148/2024 le più importanti riforme in materia, quella del 1975 (legge 19 maggio 1975, n. 151) che introdusse l’art. 230 bis del codice civile, riconoscendo al familiare che presta la propria attività di lavoro in modo continuativo nell’impresa familiare o nella famiglia a favore di un imprenditore legato da coniugio, parentela entro il terzo grado e affinità entro il secondo, diritti patrimoniali e diritti amministrativi e gestori, superando la presunzione di gratuità del rapporto familiare (affectionis vel benevolentiae causa) e quella del 2016 (legge 20 maggio 2016, n. 76) che accogliendo una concezione pluralistica della famiglia ha aggiunto l’art. 230 ter del codice civile assicurando al convivente che lavori nell’impresa familiare (non nella famiglia) una partecipazione basata sui risultati economici dell’impresa sulla base del lavoro prestato, senza altri diritti come il mantenimento o i diritti partecipativi o quelli di prelazione nell’ipotesi di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda.
 La Corte Costituzionale ha ritenuto la questione di costituzionalità fondata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione che, valutati nel loro complesso, richiedono per la convivenza di fatto una tutela che si affianca a quella della famiglia fondata sul matrimonio di cui all’art. 29 della Costituzione.
La Corte Costituzionale ha ritenuto la questione di costituzionalità fondata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione che, valutati nel loro complesso, richiedono per la convivenza di fatto una tutela che si affianca a quella della famiglia fondata sul matrimonio di cui all’art. 29 della Costituzione.
Alla luce dell’evoluzione sociale, legislativa e giurisprudenziale, nonché in considerazione della normativa europea che ha dato piena dignità alla famiglia composta dai conviventi di fatto e al fine di garantire l’effettività della tutela del lavoro reso nel contesto di un’impresa familiare, la Corte Costituzionale ha esteso la disciplina prevista dell’art. 230 bis del codice civile per i familiari che prestano la propria attività nella famiglia o nell’impresa familiare, anche ai conviventi di fatto intendendosi come tali: “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale” (art. 1, comma 36, della legge n. 76 del 2016) e conseguentemente ha dichiarato illegittimo anche l’art. 230 ter del Codice civile che riconosceva una tutela dimidiata al convivente di fatto che prestava la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente.
Alla luce della storica sentenza della Corte Costituzionale in commento, la famiglia va infatti oramai considerata sia nella versione istituzionale composta da due membri di sesso diverso o uguale uniti, rispettivamente, dal matrimonio o dall’unione civile, sia nella versione moderna costituita da coppie conviventi, rientrando entrambe nella tutela dell’art. 2 della Costituzione. Infatti la ratio legislativa di protezione che ha introdotto l’art. 230 bis del codice civile al fine di tutelare la persona che lavora in contesti di solidarietà familiare in cui ci può essere un predominio dell’imprenditore nei confronti degli altri soggetti è la medesima per i familiari così come per i conviventi.
In definitiva, è incostituzionale escludere il convivente, il quale si trova in una condizione di fatto che non differisce da quello del lavoro familiare prestato da chi è legato all’imprenditore da un rapporto di coniugio, parentela o affinità, da una norma posta a tutela del diritto del lavoro che va riconosciuto “quale strumento di realizzazione della dignità di ogni persona sia come singolo che come componente della comunità, a partire da quella familiare”.
CASSAZIONE - Sentenza n. 26160 del 17-11-2020

I contributi previdenziali sono dovuti per le ferie non godute e non retribuite nel corso del rapporto di lavoro. L’obbligo contributivo sussiste a prescindere dal fatto che l’indennità possa essere monetizzata solo alla cessazione del rapporto di lavoro che diventa, quindi, irrilevante ai fini previdenziali.
(di Marianna Abbate, Centro studi Aniv)
La Corte di Cassazione – IV Sezione Civile Lavoro – nella sentenza n. 26160 del 17/11/2020 affronta una questione giuridica di rilevanza nomofilattica e, nel sancire il principio di diritto che fra poco andremo ad analizzare, conferma pienamente l’orientamento già espresso nella prassi amministrativa dall’INPS in materia di ferie non godute e contributi previdenziali dovuti.
“Excursus processuale”
La causa in sede civile prende le mosse da un verbale di accertamento degli ispettori INPS che addebitano la contribuzione sull’importo corrispondente all’indennità sostitutiva delle ferie non godute per alcuni dipendenti di una azienda industriale, decorso il termine il termine di 18 mesi successivi all’anno di maturazione, in costanza di rapporto di lavoro. In primo grado, il Tribunale rigetta il ricorso in opposizione al verbale ispettivo a favore dell’INPS.
L’azienda impugna in appello la sentenza di primo grado: la Corte d’Appello, ribaltando la decisione di primo grado, accoglie il gravame ed annulla il verbale di accertamento. L’INPS ricorre in Cassazione con un solo motivo; resiste con controricorso l’azienda. La Corte accoglie il ricorso dell’INPS, cassa la sentenza di secondo grado impugnata e rinvia alla Corte d’Appello per un nuovo esame della controversia alla luce del seguente principio di diritto enunciato:
L’importo corrispondente all’indennità per ferie non godute costituisce base contributiva imponibile, decorso il termine di cui all’art. 10 del D.lgs. n. 66/2003 a prescindere dalla cessazione del rapporto di lavoro
"Res controversa"
Gli ispettori dell’Inps, accertata la mancata fruizione delle ferie da parte di alcuni dipendenti di un’azienda industriale nel termine di 18 mesi successivi all’anno di maturazione, in costanza di rapporto di lavoro, addebitano i contributi dovuti sull’importo corrispondente al compenso per ferie non godute, anche se non materialmente corrisposto.
Gli ispettori agiscono in base al consolidato orientamento della prassi amministrativa dell’Istituto, avallato anche dal Ministero del lavoro, secondo il quale il momento impositivo e la collocazione temporale dei contributi dovuti sul compenso delle ferie non godute coincidono con il diciottesimo mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle stesse o con il più ampio termine contrattuale, sebbene non ancora realmente corrisposto.
L’azienda contesta l’addebito contributivo adducendo la non sussistenza dell’obbligo contributivo in capo al datore di lavoro in costanza di rapporto di lavoro, alla luce del divieto di monetizzazione delle ferie non godute, se non all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003.
In sintesi, secondo la difesa di controparte, accolta in sede di gravame, la cessazione del rapporto di lavoro, costituendo il presupposto per l’insorgenza del diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, è condizione necessaria anche per l’insorgenza del corrispondente obbligo contributivo. Finché il datore di lavoro non è obbligato a “monetizzare” le ferie, non deve pagare i contributi.
Motivi del ricorso in Cassazione
Con l’unico motivo dedotto in ricorso, l’Inps afferma che l’obbligo contributivo sussiste a prescindere dalla effettiva erogazione dell’importo maturato a titolo di ferie non godute a causa dell’inadempimento del datore di lavoro e quindi a prescindere dalla cessazione del rapporto di lavoro.
La decisione della Suprema Corte
Preliminarmente il Giudice di ultima istanza, richiamando anche precedenti e consolidati orientamenti di legittimità, ribadisce che, nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie non godute costituisce retribuzione imponibile ai fini previdenziali poiché:
a) rientra nella previsione di cui all’art. 12 della Legge n. 153 del 1969 che sancisce il principio di omnicomprensitività della retribuzione imponibile, indipendentemente dall’indagine volta a stabilire la natura retributiva o risarcitoria dell’indennità stessa;
b) gode della garanzia di cui all’art. 2126, comma 2, c.c., poiché la prestazione lavorativa effettuata in luogo delle ferie è resa appunta in violazione di legge.
Tuttavia la Corte afferma che per stabilire la sussistenza dell’obbligo contributivo nella fattispecie in esame bisogna abbandonare sia il punto di vista contrattuale - interno tra lavoratore e datore di lavoro - che la disciplina privatistica delle ferie e del divieto di monetizzazione delle stesse.
La Cassazione sposta la sua attenzione sul carattere pubblicistico dell’obbligazione contributiva, affermando il principio secondo il quale l’obbligazione contributiva discende direttamente dalla legge e come tale è sottratta all’autonomia privata.
Se un lavoratore ha prestato attività lavorativa nel periodo in cui invece avrebbe dovuto godere delle ferie (costituzionalmente irrinunciabili) e il datore di lavoro si è avvantaggiato della sua maggiore produzione lavorativa, si è generata una maggiore capacità contributiva in relazione al diritto all’indennità sostitutiva delle ferie maturato dal lavoratore. L’obbligo contributivo sussiste indipendentemente dal fatto che l’indennità possa essere monetizzata solo alla cessazione del rapporto di lavoro che diventa, quindi, irrilevante ai fini previdenziali.
Il credito contributivo è indisponibile dalle parti, poiché discende dal regime previdenziale a carattere pubblico e a rilevanza costituzionale.
Normativa di riferimento:
Art. 10 del D.lgs. n. 66/2003: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del Codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione (comma 1). Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro (comma 2)”.
Art. 2126 comma 2, c.c.: “Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione [2098].”
Art. 12, comma 1, della Legge n. 153 del 1969: “Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro”.
Prassi amministrativa:
Messaggio Inps n. 118 del 08/10/2003.
CASSAZIONE - Sentenza n. 15120 del 03-06-2019

La contribuzione è dovuta anche in caso di assenze del lavoratore per ipotesi diverse da quelle previste dalla legge e/o dal Contratto Collettivo.
(di Domenica Cori, Collegio Nazionale di Tutela d Garanzia Aniv)
Con la pronuncia del 3 giugno 2019, n. 15120 la Cassazione è tornata a ribadire che, nel caso in cui il lavoratore effettui prestazioni di lavoro inferiori a quelle previste contrattualmente, per una libera scelta del datore di lavoro e non per ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa, previste dalla legge o dal Contratto Collettivo di riferimento, la contribuzione dovuta all’INPS non può essere limitata alle ore di lavoro indicate nel libro unico, bensì calcolata e versata sulle retribuzioni contrattualmente previste, anche se non corrisposte.
L’importo della retribuzione da assumere come base imponibile per il calcolo dei contributi è costituita, infatti, ai sensi dell’art. 1 comma 1 del Decreto Legge 338 del 1989, convertito con Legge 389 del 1989, dalla retribuzione contrattualmente dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, nel settore di riferimento e non da quella effettivamente erogata dal datore di lavoro, non rilevando ai fini del rapporto assicurativo (da cui derivano obblighi del tutto diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro) la circostanza che il lavoratore abbia accettato la corresponsione di compensi inferiori a quelli a lui spettanti o abbia rinunciato a far valere al riguardo i propri diritti.
È evidente infatti come il minimo imponibile sia collegato al fattore tempo e quindi l’orario normale non possa mai essere affidato alla volontà delle parti se ciò comporti una riduzione dell’imponibile. In caso contrario infatti i contributi risulterebbero tali da non potere soddisfare le finalità assicurative e previdenziali previste dal legislatore.
Un tale principio, fondato sull’autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello retributivo, si è consolidato in giurisprudenza a partire dalle Sezioni Unite n. 11199 del 2002, la quale è stata richiamata dalla sentenza in commento, che ha precisato come il principio del c.d. minimale contributivo operi anche con riferimento all’orario di lavoro.
Sul punto la Cassazione ha infatti osservato che: “...è evidente che se ai lavoratori vengono retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e su tale retribuzione viene calcolata la contribuzione non vi può essere rispetto del minimo contributivo...”. Come è noto tale obbligo del minimale contributivo è tipizzato nel settore edile ove la presenza di eventi esterni che sono imprevedibili dalle parti ha reso necessaria tale previsione. Tuttavia come precisato dalla Cassazione richiamata:
“Anche nei settori diversi da quello edile, la contribuzione è dunque dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo (quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione)”.
Un tale assunto ha importanti ripercussioni in materia di onere della prova dal momento che la Cassazione fa ricadere sul datore di lavoro nel caso di recuperi contributivi la prova dell’esenzione dell’obbligo contributivo. Segnatamente si precisa che:
“Ove dunque gli enti previdenziali e assistenziali pretendano da una impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi dell’art. 1 del D.L. 09/10/1989, n. 338, anche con riferimento all’orario di lavoro, incombe al datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di un’ipotesi eccettuativa dell’obbligo nel senso sopra individuato”.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza n. 22110 del 04-09-2019
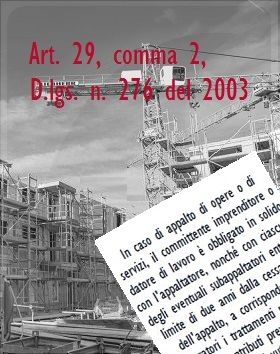
Il termine di due anni dalla cessazione dell’appalto per agire nei confronti del commttente vale soltanto per i lavoratori e non per l’inps.
(di Domenica Cori, Collegio Nazionale di Tutela d Garanzia Aniv)
Come è noto, l’art. 29, comma 2, del D.lgs. n. 276 del 2003, nella versione attualmente in vigore prevede che “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile”.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22110 del 4 settembre 2019, statuisce che il termine di decadenza dei due anni dalla cessazione dell’appalto, previsto dal legislatore, per la solidarietà negli appalti, deve intendersi riferito ai soli lavoratori che intendano fare valere spettanze in merito al trattamento economico e normativo e non si applica all’INPS.
La diversa natura dell’obbligazione contributiva rispetto a quella retributiva impone, in buona sostanza, che all’Istituto possa applicarsi soltanto il termine di prescrizione quinquennale e non quello più breve di decadenza.
Come è noto, infatti, l’obbligazione previdenziale, pur avendo origine dal rapporto di lavoro, ha natura imperativa, derivando dalla legge ed è del tutto autonoma e distinta dall’obbligazione retributiva, dovendo essere calcolata sulla base di quanto previsto dalla contrattazione collettiva vigente (c.d. “minimale contributivo”).
Sul punto vedi anche la Sentenza n. 18004 del 04-07-2019
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
CASSAZIONE - Sentenza n. 8662 del 28-03-2019

Insensibilità del debito contributivo nei confronti dell’Inps in caso di transazione fra le parti.
La sentenza della Cassazione n. 8662 del 2019 ha ribadito il principio che la transazione intervenuta fra le parti non spiega efficacia nei confronti del rapporto contributivo (cfr. tra le altre Cassazione sent. n. 19587 del 2017).
(di Domenica Cori, Collegio Nazionale di Tutela d Garanzia Aniv)
Come è noto, la transazione è un contratto tipico con il quale le parti compongono una lite intervenuta fra loro o la prevengono attraverso reciproche concessioni. Dalla disciplina codicistica emergono tre diverse forme di transazione. La prima c.d. “pura”, di cui al primo comma dell’art. 1965 del Codice Civile, con la quale le parti affiancano al precedente regolamento di interessi l’accordo transattivo; la seconda c.d. “mista” di cui al secondo comma dell’art. 1965 del Codice Civile, con la quale si creano, modificano o si estinguono rapporti diversi da quelli oggetto della contestazione fra le parti. Infine la transazione c.d. “novativa”, di cui all’art. 1976 del Codice Civile, con la quale le parti estinguono, per novazione, il precedente rapporto e lo sostituiscono con un nuovo regolamento di interessi. Al fine di una transazione novativa devono essere integrati due presupposti: l’oggettiva diversità fra il rapporto originario e quello discendente dalla transazione (c.d. “aliquid novi”) e la volontà espressa alla novazione (c.d. “animus novandi”).
È importante ricordare che la transazione, ai sensi dell’art. 1967 del Codice Civile, deve essere provata per iscritto, mentre la forma per iscritto a pena di nullità del contratto sussiste solo per i casi di cui all’art. 1350, n. 1-11 del Codice Civile e quando parte contrattuale sia la P.A.
La fattispecie esaminata dalla Cassazione, in commento, aveva ad oggetto un accordo intervenuto nella forma di una transazione novativa al fine di comporre il contenzioso pendente fra un lavoratore e controparti datoriali per lo svolgimento di mansioni dirigenziali.
L’efficacia novativa della transazione aveva comportato, ai sensi dell’art. 1230 del Codice Civile, che disciplina l’ipotesi della novazione oggettiva, l’estinzione del precedente rapporto giuridico e la sostituzione ad esso di uno nuovo.
Un tale accordo per la Cassazione spiega effetti sul rapporto lavorativo, ma non su quello previdenziale, dal momento che quest’ultimo, pur scaturendo dal primo ne resta autonomo e distinto.
Il rapporto contributivo, il quale fa capo ad un soggetto terzo, si connota infatti per profili pubblicistici che non sono nella disponibilità delle parti del rapporto lavorativo e permane indipendentemente dagli obblighi retributivi, fondandosi su tutto ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere e quindi anche se le obbligazioni retributive non siano state soddisfatte, ovvero persino qualora il lavoratore abbia rinunziato ai suoi diritti.
In conclusione, la transazione intervenuta tra lavoratore e datore di lavoro è estranea al rapporto tra quest’ultimo e l’INPS e l’Istituto può provare, con qualsiasi mezzo e anche in via presuntiva, gli imponibili assoggettabili a contribuzione.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Delega di funzioni e responsabilità civile del datore di lavoro

La Cassazione, con ordinanza n. 12753/2019, rinnova il suo orientamento in punto di delega delle funzioni di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, non escludendo la responsabilità civile del datore di lavoro per l’infortunio di un dipendente. In particolare, ad avviso della Suprema Corte, la delega delle funzioni di prevenzione e protezione, e quindi anche del controllo sull’osservanza delle stesse, non esonera il datore di lavoro dall’eventuale responsabilità civile per l’infortunio.
(di Giuseppe Gentile, Coordinatore scientifico Centro studi Aniv)
Il punto controverso
La sentenza dei giudici di appello aveva assolto la società datrice di lavoro dall’accusa, formulata dall’infortunato, di aver omesso il controllo sull’osservanza delle misure di prevenzione, affermando che essa aveva delegato tale funzione di controllo al preposto al cantiere.
In giudizio era emerso che il ricorrente aveva subito un infortunio sul lavoro (consistente nel danno ad un occhio) nel mentre stava svolgendo un’attività alle dipendenze della società datrice di lavoro, convenuta in giudizio congiuntamente al legale rappresentante.
La Corte territoriale aveva ritenuto, ai fini che qui interessano, che doveva darsi per pacifico che l'incidente fosse avvenuto durante un’attività di lavoro dipendente, anche se non regolare, atteso che il danneggiato stava utilizzando un flessibile senza occhiali di protezione. Era da ritenere dimostrato, inoltre, che i dispositivi di protezione erano stati consegnati ai dipendenti ed era stata eseguita una corretta attività di informazione.
Parimenti, la Corte aveva escluso che la convenuta società ed il legale rappresentante potessero essere ritenuti responsabili dell'accaduto, atteso che, pur rivestendo quest’ultimo il ruolo di amministratore unico della società, il soggetto realmente preposto alla vigilanza ed al quotidiano controllo dei lavoratori era in realtà un altro dipendente, padre del convenuto. Pertanto, rivestendo quest'ultimo il ruolo di preposto, non era possibile ravvisare in capo al legale rappresentante della società la commissione di un illecito, essendo stato dimostrato che i dispositivi di protezione erano stati consegnati e che non vi era stata alcuna omissione di controllo sui dipendenti.
Leggi tutto: Delega di funzioni e responsabilità civile del datore di lavoro
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza n. 18004 del 04-07-2019

Solidarietà contributiva negli appalti - Termine di decadenza biennale di cui all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 - Non si applica all'azione degli Enti previdenziali, soggetta alla sola prescrizione quinquennale.
(di Simona Di Cerbo, Centro studi Aniv)
Con la sentenza del 4 Luglio 2019 n. 18004 la Suprema Corte è intervenuta nella materia della solidarietà contributiva negli appalti, sancendo il principio secondo cui il termine di decadenza biennale, contemplato dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003, non è applicabile all'azione promossa dagli Enti previdenziali, essendo la stessa soggetta alla sola prescrizione quinquennale.
In buona sostanza secondo i Giudici di Legittimità - che hanno guardato ad una interpretazione sistematica dei principi ordinamentali attraverso una esegesi della ratio legis che sottende il sistema stesso della tutela previdenziale – l’efficacia del termine decadenziale de quo non può estendersi anche a soggetti terzi, nella fattispecie l’Inps, i cui diritti pur traendo origine dal rapporto di lavoro (si sottraggono al termine di decadenza biennale e) restano soggetti esclusivamente al termine di prescrizione quinquennale. Ciò in quanto l’obbligo contributivo e quello retributivo rispondono ad una funzione diversa e sono distinti per natura, ambito di applicazione e rilevanza sociale.
Con una visione d’insieme della tutela previdenziale, la Corte sancisce altresì il concetto per cui la finalità della pretesa contributiva è volta alla soddisfazione di un interesse indiretto del lavoratore, ma che è interesse diretto della collettività, per il finanziamento del sistema previdenziale.
Leggi tutto: CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza n. 18004 del 04-07-2019
Corte di giustizia Ue - Orario di lavoro giornaliero
Secondo la Corte UE le imprese sono obbligate a registrare l'orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore. Si ritorna al registro presenze?

Nella controversia tra una banca e un sindacato spagnolo, la Corte UE, interpretando la Direttiva 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, con la sentenza del 14 maggio 2019 sancisce che l’orario di lavoro va misurato in modo «oggettivo, affidabile e accessibile» ogni giorno e per ciascun lavoratore. Saranno gli Stati membri a dover introdurre l’obbligo per i datori di lavoro di istituire un sistema che consenta la misurazione della durata dell'orario di lavoro giornaliero. Se recepita nel nostro ordinamento potrebbe significare il ritorno al vecchio registro presenze, magari in formato elettronico.
Sentenza Foodora - Al rider la retribuzione sulla base del CCNL
La Corte d’Appello di Torino, sezione Lavoro, con la sentenza n. 26/2019, ha riconosciuto il diritto per i riders a percepire la retribuzione prevista dal contratto collettivo di lavoro del settore Logistica e Trasporto merci.
(di Michele Martino)

I riders sono i fattorini che consegnano a domicilio un prodotto ordinato tramite una piattaforma online di cibo a domicilio (ma non solo). Il datore di lavoro, però, non è il ristorante o la pizzeria che prepara il cibo da asporto, bensì la società proprietaria del sito internet, tipo Deliveroo o Foodora, solo per citarne qualcuna. In pratica, mediante una app o tramite il sito internet della società, i clienti possono consultare gli esercizi (es. i ristoranti), vicino alla posizione dove desiderano che sia consegnato il cibo. Quindi compilano un ordine ed aspettano che un rider (corriere munito di uno smartphone e di bicicletta o motorino) arrivi a consegnare il tutto.
L'attività svolta dai riders rientra nel vasto e poco esplorato ambito delle occasioni di lavoro offerte dalla c.d. economia digitale (gig economy, sharing economy), vale a dire tutte quelle (nuove) prestazioni lavorative collegate alla rete internet ed all'e-commerce. Sullo stesso argomento vedi:
Tipico esempio di sharing economy è BlaBlaCar, una piattaforma web di car pooling che opera in 22 Stati e conta più di 25 milioni di associati, la quale consente a chi deve spostarsi con la propria macchina fra due località, più o meno distanti, di accettare, eventualmente, dei passeggeri a bordo, interessati a quel tragitto. Mentre Foodora è un tipico esempio di gig economy, un modello economico che implica l’erogazione di beni e servizi on demand, gestiti tramite una APP che stabilisce le tariffe e anche quanto debba percepire l'addetto alla consegna (il rider, appunto).
Furono proprio alcuni riders di Foodora ad aver intentato, per primi, una causa civile contro la società tedesca, dopo essere stati licenziati a causa delle proteste di piazza del 2016 tese ad ottenere un giusto trattamento economico e normativo. I lavoratori, assunti con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (a tempo determinato), avevano chiesto al Tribunale di Torino di accertare la natura subordinata del proprio rapporto di lavoro, la nullità del licenziamento e la corresponsione delle conseguenti differenze retributive. Il Tribunale del lavoro di Torino, nel mese di aprile 2018, ha respinto il ricorso ritenendo che i riders sono collaboratori autonomi non legati da un rapporto di lavoro subordinato con l’azienda (Sentenza n. 778 dell'11 aprile 2018).
La Corte d’Appello, con la sentenza n. 26/2019, ha deciso invece di riconoscere ai lavoratori il diritto ad essere retribuiti sulla base del contratto collettivo di lavoro della logistica trasporto merci. Il pilastro normativo su cui poggia la decisione della Corte è fornito sostanzialmente dall'articolo 2 del D. Lgs. 81/2015, laddove prevede che "... dal 1° gennaio 2016 la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro."
La sentenza de quo potrebbe essere l'occasione per indurre Governo, Parti sociali e tutti gli altri attori che si occupano del mondo del lavoro, a sedersi intorno ad un tavolo per disciplinare maggiormente un settore dove occorre stabilire quali forme di tutela, quali regole, quali retribuzioni devono essere assicurate ai lavoratori dell'economia digitale e del complesso sistema che continuamente evolve intorno ad essa.



